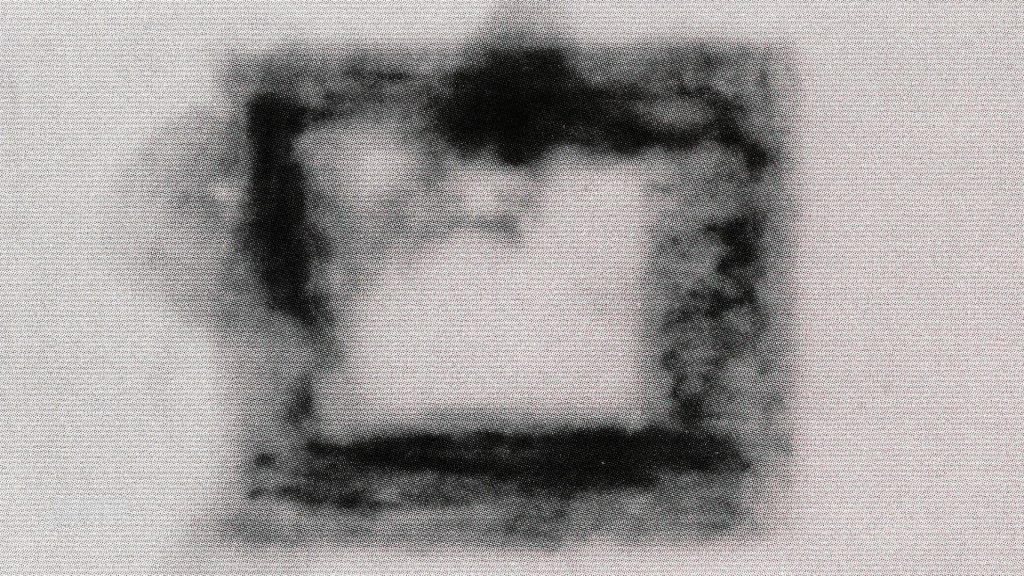Perché non serve a niente, davvero, che tu ti tieni gli occhi spalancati.
850 film da più di 65 paesi rispondono all’appello Laterale per esplorare l’invisibile ancora una volta. Filmmakers da tutto il mondo indagano spazi familiari e lontani, mondi limitrofi o impensati, nel tentativo di chiedere, per l’ottavo anno, qualcosa di più al cinema.
Così febbrilmente intenti nell’esplorare la regione dello sguardo, si compie quel passo che fa sconfinare. Si va dall’altra parte dell’occhio: è possibile un cinema che guardi dall’altra parte? È possibile trovare dei film nelle stelle che appaiono quando ci sfreghiamo gli occhi? Non sono forse dei film i caleidoscopi che vediamo (sentiamo?) impressi sul retro delle nostre palpebre, proiettati negli otturatori naturali al centro del nostro cranio?
Lo sforzo non è immaginativo, beninteso, è attentivo, ed è più facile farlo ad occhi aperti. Da bambini si faceva spesso questo esperimento cinematografico mossi dalla sola curiosità per quello strano macchinario che è l’occhio. Proviamolo: guardiamo un punto fisso davanti a noi allentando l’attenzione sugli oggetti in sé e concentrandosi sull’aria, senza sbattere le palpebre. Infiniti puntini si muovono furiosamente senza nascondersi, come se riuscissimo a percepire per chissà quale miracolo la materia che tenta di resistere alla sua inevitabile disgregazione. Ora muoviamo rapidamente gli occhi verso un altro punto del campo: un altro miracolo ci permette di trattenere per meno di un’istante l’immagine residua del precedente fotogramma. Più a lungo si resta nel primo passaggio dell’esperimento, più forte sarà l’impressione luminosa nel secondo. Il protocollo per vedere i film dall’altra parte dell’occhio è certo differente, e forse ancora incompleto – ma si deve pur sempre partire da qualcosa.
Le opere grandi, al pari dei corpi celesti, posseggono un’alta forza d’attrazione – la chiamiamo comunemente “Storia”. La forza attrattiva delle grandi opere, infatti, è spesso cementificata dal tempo piuttosto che dallo spazio. Il paradiso Perduto attrae per la sua resistenza al tempo che scorre, si ingigantisce con l’accumularsi di strati (strade/percorsi), si autocostruisce sulle fondamenta del suo stesso relitto. Certe opere ci chiamano a uno sforzo non da poco, ci chiamano a una responsabilità critica che crei distacco, ci chiedono di ripartire ogni volta dal relitto, dal momento che la storia dell’arte non procede in maniera lineare ma nel rapporto costante tra il presente e il passato (e si consolida retrospettivamente) – e così Milton deve parte del valore della sua opera a Doré e Goethe deve qualcosa a Murnau (Faust).
Le opere piccole sono sottilmente esigenti, danzano e piangono sugli «invisibili atti dello spirito umano: così sottili e così piccoli che muoiono quando vengono portati fuori sotto i riflettori», e «non fanno la storia contemporanea, ma neppure la storia dell’arte o qualsiasi altra storia» (Mekas). Ci chiamano a uno sforzo intellettuale diverso, ché celebrare il battito d’ali di una farfalla è sicuramente più dispendioso che assistere all’estenuante (in maniera opposta) gioco di pose invadenti della pavoneggiante produzione audiovisiva contemporanea. Ci chiamano a una responsabilità attentiva che ci allontani dal concetto di trend, di saga, di re-qualcosa, in questo ridondante perpetuarsi dell’uguale mascherato da nuovo(=uguale), giacché tutto sembra oramai diventare sequel prequel remake trasposizione di qualcosa che non ha manco avuto tempo di farsi passato. Ci chiamano alla concentrazione, fosse anche sul nulla («In verità, un foglio bianco/Dichiara attraverso il vuoto/Che non c’è niente di più bello/Come ciò che non esiste», da La Feuille Blanche di Paul Valéry), fosse anche su quell’insignificante quotidiano uguale(=nuovo) che però dialoga da sempre e per sempre con gli artisti di ogni epoca, senza esaurirsi, senza mai essere una copia – la materia, quella vera, non si offre mai più di una volta agli occhi. Le stelle, le si guardano da sempre. Eppure le loro vite sono così incommensurabilmente lunghe, la loro forma sempre identica. Ci sono stelle minuscole, nel nostro cielo, che condividiamo con i primi uomini apparsi sulla Terra: ancora oggi la loro luce si offre al nostro sguardo. Immobili stanno lì, e senza sosta le abbiamo rappresentate in tutte le epoche e con ogni mezzo – «Il cielo è lo schermo più misconosciuto» (Saint-Pol-Roux).
Lo schermo pieno di stelle (quelle vere, non i cangianti manichini imbellettati che comunque prendono il nome di stelle) non smette di produrre immagini sempre nuove. Non serve ri-truccare e ri-acconciare stelle di film in film, non serve a niente riguardare questo sempre diverso identico gioco di pose in un’arte naturale come il cinema. Non serve a niente, infine, pensare che sia tutta una questione di visibilità. La posa richiama la vista e contemporaneamente la devia, la distrae, la focalizza sull’irrilevante orpellato. Più le sale si riempiono di stelle, più bisogna volgere lo sguardo di lato, operare questo sforzo attentivo che ci pareva così sensato da piccoli. Perché non serve a niente, davvero, che tu ti tieni gli occhi spalancati. Cerchiamo altro nel cielo: le opere invisibili, ad esempio, quelle dall’altra parte dell’occhio. Cosa ci chiedono, queste opere non ancora immaginate? Da dove partiamo?
Lo sguardo Laterale si rivolge al passato e il passato risponde: dal 1969 Edoardo Sanguineti scrive per noi (non si prendano queste parole come poetismo o metafora di alcun tipo) un protocollo per i film dell’edizione 2024, per il pubblico, gli scrittori, i conferenzieri, i curatori.
Che un esperimento di cinema diventi esso stesso cinema:
Schiàcciati gli occhi, nel buio, sfrègateli con le dita, adagio, adesso che siamo qui, per riposare, in questa oscurità che è così completa, tutta, che noi ce la guardiamo come se fossimo due morti, e non vediamo, invece, naturalmente, niente. Perché non serve niente, davvero, che tu ti tieni gli occhi spalancati, tu che non puoi vedere che questo niente, adesso, invece.
Ma se tu fai così con gli occhi, che te li schiacci e te li sfreghi come te lo dico io, ma adagio, è ancora molto meglio che se tu te lo guardi, il mondo, anche quando tu sei nel giorno, così nella luce, nel sole. Perché quello che tu vedi, se fai così con gli occhi, sono proprio i colori delle cose, soltanto, e cioè proprio i colori del mondo, come dici tu.
E così puoi anche vederti il cielo, con le sue nuvole, e il fuoco, e gli animali che se ne stanno giù, nel fondo del mare, con la sabbia, con l’acqua. Ma questo, io ti dico che è un cielo che è più cielo del cielo, questo che tu ti vedi dentro gli occhi, e anche il fuoco, poi, quello è un altro fuoco, che è come quello che tu potrai vederti soltanto quando sarai morto, e che forse è quello che tu ti vedevi prima di nascere, quel fuoco, quando tu non eri ancora niente, appunto, e non c’erano che queste immagini, allora, ma come un po’ vaghe, così, delle cose, ma anche più vere, però, tanto, e più inquiete, e io voglio dire, insomma, più vive.
Perché poi, vedi, cambiano sempre. Certo, è un po’ come un caleidoscopio, si capisce, se vuoi, quando tu te lo giri tra le dita, così. Ma qui, però, non c’è niente che sia così geometrico, poi, e così duro, insomma. Qui tutto è tutto molto molle invece. E poi, questo caleidoscopio, in fondo, tu ce l’hai dentro, e le cose che tu ci vedi, dentro, e cioè queste forme, questi colori che ti cambiano sempre, tu non lo sai, veramente, dentro di te, tu, dove sono.
Perché poi non stanno, veramente, dentro di te, e non stanno poi nemmeno fuori, niente. Perché questi colori, vedi, sei poi tu, in fondo, sei tu che li guardi, questi colori, dentro di te, fuori di te, non sappiamo, non so, e cioè è che questi colori sono te, ecco, perché tu sei questi colori, allora, e poi non c’è altro, non sei altro, tu, niente.Edoardo Sanguineti, Teatro. K-Passaggio-Traumdeutung-Protocolli (1969)